Gruppi
compatti per l’astrofilo
Enrico Prosperi
Articolo pubblicato sul numero 205 (gennaio 2000)
della rivista
l'Astronomia, rubrica Profondo Cielo
|
Due articoli apparsi sul numero di luglio
della rivista, a firma di R. P. Saglia, D. Mehlert e A. Diaferio, trattano
delle più recenti teorie sull'evoluzione gerarchica
delle galassie. In particolare, si sottolinea l'importanza dello studio
dei gruppi compatti di galassie. Essendo questi oggetti solitamente indagati
con grossi telescopi professionali, ci siamo chiesti se possano essere
alla portata anche di astrofili dotati di strumenti adeguati. Ho pertanto
preso in esame l'archivio delle mie riprese CCD, ho ricercato gli oggetti
di Hickson e in effetti ho trovato una dozzina di gruppi compatti che compaiono
fra i cento del suo catalogo.
Date le piccole dimensioni e la bassa luminosità
superficiale di questi oggetti, per la ripresa digitale occorre un
telescopio di almeno 20 cm di apertura e una camera CCD dalle buone prestazioni,
mentre è necessario un 35-40 cm, l'impiego di forti ingrandimenti
(100-300x) e cieli estremamente bui per l'osservazione visuale.
Naturalmente, l'indagine amatoriale non può andare
oltre i limiti del semplice esame morfologico e quindi il contributo scientifico
è senz'altro limitato. E' tuttavia da sottolineare che la pubblicazione
del Catalogo di Hickson è abbastanza
recente (1982) e che la scoperta di alcuni dei gruppi più compatti
si colloca temporalmente negli ultimi decenni. La tecnica ha evidentemente
spinto in avanti le potenzialità degli astrofili, come pure quelle
degli astronomi professionisti, riducendo, però, le distanze almeno
per quanto concerne l'osservazione nella banda ottica e nel vicino infrarosso. |
|
|
Gruppi
e ammassi
Le galassie isolate sono piuttosto rare nell'Universo.
Esse tendono infatti a formare gruppi e ammassi: un sistema che contiene
più di due e fino a diverse dozzine di galassie si dice gruppo;
un sistema che ne comprende centinaia, fino ad alcune decine di migliaia,
costituisce un ammasso.
Contrariamente a ciò che si osserva negli ammassi,
di solito le galassie dei gruppi sono distribuite con densità piuttosto
bassa. Per esempio, chi guardasse verso di noi da una distanza di qualche
decina di milioni di anni luce, vedrebbe solo le tre maggiori galassie
del Gruppo Locale: la Via Lattea, la galassia di Andromeda
(M31) e quella del Triangolo (M33) insieme a poche
altre, di piccole dimensioni e satelliti di queste; i satelliti distano
dalle galassie maggiori tra dieci e venti volte il loro piccolo diametro.
Tuttavia, non è infrequente che si vedano anche
coppie o triplette di galassie separate da distanze di molto inferiori.
Eccezionalmente esistono anche gruppi di galassie i cui membri si affollano
in uno spazio così ristretto che sembrano toccarsi l'un l'altro.
Sono i cosiddetti gruppi compatti.
E’ ragionevole supporre che i fenomeni di collisione
e di fusione di galassie che avvengono nelle regioni centrali degli ammassi
si verifichino anche nei gruppi compatti, che rappresentano perciò
laboratori naturali ideali per studiare i processi di interazione. |
|
|
Paul Hickson, astronomo canadese dell'Università
della Colombia Britannica, vent’anni fa condusse una ricerca sistematica
di questi gruppi sulle lastre sensibili al rosso della Palomar Sky Survey,
includendoli nel suo Catalogo solo se il gruppo compatto soddisfa tre rigidi
criteri: di popolazione (il gruppo deve essere costituito da almeno
quattro membri), di compattezza e di isolamento (per escludere
quelle che sono semplici condensazioni all’interno di ammassi ricchi).
Alcuni dei gruppi compatti di Hickson sono ben
noti agli astrofili. Basti citare il Quintetto di Stephan, nel Pegaso,
a poca distanza dalla galassia a spirale NGC 7331. La presenza di
evidenti distorsioni mareali, in questo e in altri gruppi, implica che
la vicinanza in cielo delle galassie che li costituiscono è reale
e non solo prospettica. |
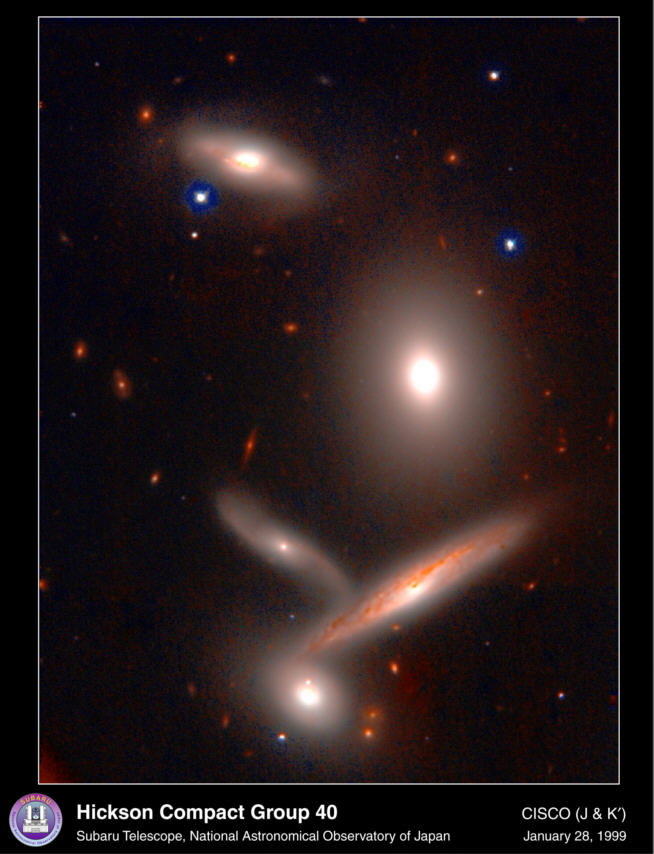 |
|
|
Figura 1. HCG 40 è
stato oggetto di una delle prime osservazioni del nuovo telescopio nazionale
giapponese Subaru, di 8,3 m di diametro, sito a Mauna Kea, Hawaii. Dal
basso verso l'alto, le cinque galassie del gruppo sono, nell'ordine, una
spirale, un'ellittica, ancora due spirali e una lenticolare (S0). Nell'immagine
appaiono chiaramente in contatto l'una con l'altra; evidenti i risultati
delle forti interazioni mareali, specie sulle spirali. I due oggetti puntiformi,
di colore bianco, sono stelle della nostra Galassia; quelli rossastri sono
invece galassie lontane miliardi di anni luce. (http://www.naoj.org/index.html) |
|
|
Una
piccola antologia
Ed ora muoviamoci un po’ tra alcuni dei gruppi compatti
più prossimi e perciò più facili per l’astrofilo.
HCG
7
Il membro più luminoso (NGC
192) è moderatamente brillante, alquanto piccolo, elongato
in direzione NNO - SSE, con nucleo brillante. NGC
196 si trova 3’ a nord-est e appare piuttosto debole, molto
piccolo, rotondo, con un piccolo nucleo luminoso. Forma una coppia assai
ravvicinata con NGC 197, appena 1’
a sud e che, in realtà, si mostra come un nodulo estremamente piccolo
e debole. Il membro più esteso è NGC
201, debole, moderatamente esteso, con una luminosità
superficiale alquanto bassa e regolare, leggermente elongato in direzione
NO-SE. Sono appena visibili due deboli bracci che si avvolgono a formare
una S. |
 |
 |
HCG
10
E’ uno dei più luminosi fra i gruppi compatti.
NGC
536 è moderatamente brillante, leggermente elongata in
direzione OSO - ENE. NGC 529, spostata
di 8’,5 a ovest, è pure moderatamente brillante, alquanto piccola,
con un nucleo brillante. NGC 531 è
debole, piccola, ovale con orientamento SO-NE.
NGC
542 è anch'essa debole, diffusa, leggermente elongata. |
HCG
16
E’ un quartetto brillante costituito da NGC
835, una galassia di forma rotonda, piccola, moderatamente brillante
con un nucleo luminoso, che forma una coppia con NGC
833, 1’ a ovest, una galassia moderatamente brillante,
disposta di profilo e orientata in direzione est-ovest con un nucleo luminoso.
Anche NGC 839 è disposta di
profilo con orientamento est-ovest. Infine, NGC
838 è piuttosto debole, leggermente elongata, con un
nucleo luminoso assai piccolo e di aspetto stellare. |
 |
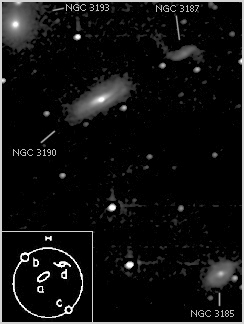 |
A metà strada tra la bella
doppia gamma Leo e zeta Leo, si trova il brillante quartetto HCG
44 nel Leone, consistente di NGC
3185, 3187, 3190
e 3193. I tre membri più luminosi
sono visibili con un telescopio di 20 cm e sono allineati da sud-ovest
a nord-est. Si tratta del più esteso (e forse il più vicino)
e più bello, per la varietà morfologica, tra i gruppi compatti
di questa rassegna. NGC 3190 è
una galassia di magnitudine 11 disposta di taglio e orientata in
senso NE-SO con un nucleo di aspetto stellare. Un disco equatoriale di
polveri rappresenta un soggetto difficile per l'osservazione visuale anche
con diametri ragguardevoli. Ellittica prominente di magnitudine 11, NGC
3193 si colloca 6’ a nord-est e appena a 1’ a sud di una stella
di campo di magnitudine 9. Dal lato opposto di NGC
3190 si trova una spirale barrata in posizione quasi frontale,
NGC
3185, con un più diffuso alone. Il membro più
debole è NGC 3187, disposto
di profilo e di magnitudine 13,5. Il suo asse maggiore risulta quasi perfettamente
allineato con la più brillante
NGC 3190 appena 5’ a sud-est. |
| Un altro oggetto per
un 20 cm è HCG 68 nei
Cani da Caccia, situato 8° a sud-est di M51, la Galassia Vortice. I
due membri più brillanti sono NGC 5353
e NGC 5354, di magnitudine 11, che
formano una coppia ravvicinata di 1’,2. La più estesa galassia del
gruppo, NGC 5350, appare nelle immagini
fotografiche e CCD come una spirale barrata, circa 4’ a nord, mentre visualmente
si mostra come un diffuso alone, anche se una stella di magnitudine 6,5
appena 3’ a sud-ovest ne disturba la visione. I due membri restanti, NGC
5355 e 5358, richiedono
probabilmente un'apertura di 25-30 cm. |
 |
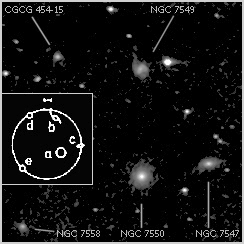 |
I cinque membri del quintetto
HCG
93 si trovano all'interno di un ampio raggruppamento di
deboli galassie NGC. Il membro più luminoso, NGC
7550, è un'ellittica moderatamente brillante, con un
alone di dimensioni 1’,5x1’,2 esteso in direzione nord-sud. L'alone è
nettamente concentrato con una porzione centrale rotonda e brillante e
un nucleo di aspetto quasi stellare. Appena 3’ a ovest è visibile
NGC
7547, un debole ovale orientato in direzione est-ovest con una
debole concentrazione centrale. NGC 7549
si colloca 5’ a nord di NGC 7550 e
segue una stella di magnitudine 10,5. Si tratta di una spirale barrata
con una porzione centrale debole e di forma ovale, elongata in direzione
nord-sud con bracci esili e appena visibili. A circa 4’ HCG
93D appare come un chiarore assai debole di soli 20” di diametro.
Una debole stella doppia 1’ a sud-est, appare a momenti come un oggetto
diffuso che può indurre confusione. Il membro più difficile,
HCG
93E, è un nodulo di 20” al margine sud-est del gruppo
e richiede particolare attenzione. Esso risulta sul prolungamento di un
paio di stelle di magnitudine 14,5 orientate da nord a sud che si trovano
2’,5 a sud (non si vedono nell'immagine CCD). |
|
|
|
I
più compatti in assoluto
Alcuni dei gruppi più compatti sono deboli e di
difficile individuazione. L'osservazione visuale richiede strumenti di
notevole apertura e forti ingrandimenti.
| HCG
40A è la galassia più brillante del gruppo compatto
HCG
40, composto da 5 membri. Molto debole, assai piccola e
rotonda. Nel gruppo ci sono anche HCG 40D
a nord-est, HCG 40B 1’,1 a SSE e HCG
40C a sud. Quest’ultimo è un oggetto elongato che si
colloca appena 40” a sud del nucleo di HCG 40A e 30” a nord-ovest
di HCG 40B; quest’ultima appare assai debole, estremamente piccola,
rotonda. HCG 40D è piccola,
elongata 3:2 in direzione est-ovest. Il gruppo si colloca a una distanza
di 300 milioni di anni-luce, nella costellazione dell'Idra. I suoi membri
sono così stretti che paiono toccarsi. |
 |
Rimarchevole catena di
galassie, HCG 56 nell'Orsa Maggiore,
si trova appena 7’ a sud della spirale barrata NGC 3718. Viene descritto
come "una catena di 4 galassie, tra loro connesse, che copre una lunghezza
di 90”, corrispondente a circa 150 mila anni-luce. La quinta galassia è
a circa 65” ed è probabilmente alla stessa distanza". Le immagini
fotografiche e CCD rivelano tutti e cinque i membri, con il trio
centrale che appare come una catena connessa, ma distinguere i singoli
membri visualmente rappresenta una sfida per gli appassionati di oggetti
di profondo cielo.
A 100x, questo gruppo compatto si fonde in una debole
macchiolina elongata appena 1’ in lunghezza, in direzione est-ovest in
rapporto di 3:1. Aumentando gli ingrandimenti a 220 si risolvono un paio
di noduli alle estremità est e ovest. Utilizzando il famoso
telescopio di 72 pollici, il “Leviatano” di Lord Rosse a Parsonstown, in
Irlanda, fu esaminato il campo di NGC 3718 per quattro volte tra
il 1852 e il 1868 e la catena di galassie non fu mai neppure sospettata,
cosicché anche la sola rivelazione di questo gruppo rappresenta
un'esperienza di una certa soddisfazione. |
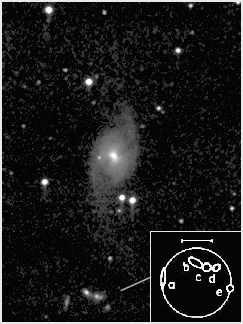 |
| HCG
57 nel Leone è meglio conosciuto come Settetto di
Copeland e fu scoperto il 9 febbraio del 1874 da Ralph Copeland, un assistente
di Lord Rosse. Questo gruppo dista 600 milioni di anni-luce, è composto
di sette galassie contenute all'interno di un cerchio di 5’ e richiede
un telescopio di 25-30 cm per una visione decente. Sfortunatamente, Copeland
confuse l'area con il campo di una regione vicina contenente due deboli
galassie e ridusse la posizione utilizzando stelle di riferimento errate,
tanto che nei vecchi cataloghi il gruppo è denotato come “non esistente”;
i cataloghi più recenti lo elencano nella posizione corretta. |
| NGC 3753 è
il membro più brillante con una magnitudine di 13,6. Appare debole,
piccolo, elongato 5:2 in direzione ONO-ESE, con un nucleo brillante; è
deformato, in particolare nella porzione orientale, a causa probabilmente
di un incontro ravvicinato con una vicina galassia. NGC
3750 è una debole compagna appena 0’,7 a sud-ovest, che
appare come un nodulo rotondo e assai piccolo. Ancora più debole
è NGC 3754, situata quasi sul
bordo nord-est di NGC 3753. Un
secondo stretto trio è localizzato circa 3’ a nord-ovest: l’oggetto
più cospicuo dei tre, NGC 3746,
ha magnitudine 14,2: sebbene le riprese fotografiche mostrino una
spirale barrata, visualmente si nota solo una macchiolina rotonda e senza
particolari. Due deboli barlumi, NGC 3745
e NGC 3748, sono appena visibili 1’
a nord e 2’ a nord-est, rispettivamente. Infine, a meno di 3’ a sud di
NGC
3753 si trova NGC 3751. |
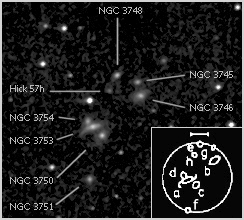 |
| Il Sestetto
di Seyfert (HCG 79)
costituisce un oggetto interessante e difficile e richiede un elevato ingrandimento
per risolvere i tre componenti principali: il membro più luminoso,
NGC
6027E, debole, piccolo, elongato in direzione E-O e i vicini
NGC
6027A, 36” a SSO, e NGC 6027B,
appena 24” a ovest. E’ uno dei gruppi più compatti che si conoscano,
occupando un volume più piccolo di quello della Via Lattea. Classificato
originariamente come composto da sei galassie, studi più recenti
hanno messo in evidenza che la galassia più debole è in realtà
un'estensione diffusa di una vicina maggiore, senza dubbio la prova di
un'interazione gravitazionale in atto. Osservazioni radio hanno rivelato
che l'intero gruppo giace all'interno di un esteso alone di idrogeno neutro,
probabilmente a causa della spoliazione di gas dalle singole galassie dovuto
agli effetti di marea. E’ probabile che il gruppo alla fine si fonderà
a formare una singola galassia ellittica di grandi dimensioni. |
 |
| Il Quintetto
di Stephan (HCG 92,
nel Pegaso) è forse il più famoso tra i gruppi compatti.
Appare come un flebile chiarore già con un 20 cm e la rivelazione
è emozionante. Con aperture maggiori si può tentare di estrarre
qualche dettaglio in più. L'intero gruppo risulta stipato in un
cerchio di 4’, cosicché risultano necessari elevati ingrandimenti
per risolvere i singoli membri. Il più esteso, NGC
7320, misura 1’,5x0’,7, con una porzione centrale gradualmente
più luminosa. |
| Al lato sud-est si trova sovrapposta una stella di magnitudine
14,5. NGC 7318 è un sistema
doppio interagente di magnitudine 13 e si risolvono visualmente due nuclei
stellari all'interno di un comune alone che si allunga orientandosi approssimativamente
in direzione est-ovest. Appena 1’,6 a sud-est si trova NGC
7317. Una stella di magnitudine 13 al limite nord-ovest, ad
appena 16” dal centro, confonde le osservazioni poiché la galassia
appare, a prima vista, doppia. Il membro più debole del Quintetto
è NGC 7319 che appare come una
macchia con una bassa luminosità superficiale 1’,7 a nord di NGC
7320. Appena 3’ a est si nota nell'immagine CCD la tenue NGC
7320c, che non risulta inclusa nel gruppo. Quattro delle galassie
presentano redshift di circa 6600 km/s, mentre NGC
7320 ha un redshift molto inferiore (760 km/s) e non mostra
evidenti distorsioni di marea. Probabilmente, la presenza di quest'ultima
galassia è semplicemente dovuta a una proiezione casuale nel campo
del gruppo, che risulta pertanto costituito da quattro galassie. |
 |
| Sempre nel Pegaso, HCG
94 è un gruppo compatto pregevole composto da sette
galassie, di cui però soltanto quattro hanno magnitudine superiore
alla 16. NGC 7578A, di magnitudine
13,3 e dimensioni 1’,8*1’,2, forma una coppia assai stretta con NGC
7578B, di magnitudine 14,0 e più piccola (1’,0*1’,0),
che si trova 35” a nord-est. L'intero gruppo risulta stipato in uno spazio
di circa 200 mila anni luce. Incontri ravvicinati tra galassie possono
portare alla distruzione dei membri più piccoli allorché
le stelle e i gas vengono strappati via e raccolti in un esteso alone che
circonda le galassie più grandi. Man mano che il gas viene estratto
dalle galassie vicine, esso precipita nel gorgo gravitazionale costituito
dalla galassia maggiore. Il gas in caduta viene compresso e riscaldato
a temperature superiori ai 10 milioni di gradi e irradia nella banda dei
raggi X. |
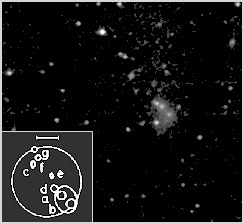 |
| Un'attenta analisi di questa radiazione X
fornisce importanti indizi sui processi di fusione: Rachel Pildis dell'Università
del Michigan, utilizzando le immagini X del satellite ROSAT e osservazioni
nell’ottico dell'Osservatorio di Kitt Peak, ha mostrato che le galassie
di HCG 94 vengono smembrate e che si stanno ricomponendo a formare
una galassia supergigante. |
 |
 |
Figura 2a e 2b
Il sestetto di Seyfert ripreso
dal telescopio di 2,1 m dell'Osservatorio di Kitt Peak. Nel riquadro, i
vari componenti sono identificati dalla loro designazione nel catalogo
RC3, con lettere maiuscole, e con le lettere minuscole utilizzate dallo
stesso Seyfert; seguono i redshift in km/s. Si noti come i redshift dei
componenti del gruppo siano assai simili tra loro, da 4000 a 4500 km/s,
ad eccezione di quello al centro, che è di circa 20 mila km/s. Comunemente
si crede che ciò sia dovuto alla proiezione casuale di una galassia
più distante. Alcuni invece ritengono che ciò richieda un
totale ripensamento della moderna cosmologia. |
 |
Figura 3. http://astro.caltech.edu/mirror/keck/realpublic/gen_info/gallery/space.html
- W.M. Keck Observatory
Un'immagine del "Settetto di Copeland"
(HCG 57) ripresa dall'Osservatorio W.M. Keck, Mauna Kea, Hawaii. Non sono
visibili in questa immagine le decine di milioni di stelle che sembrano
essere strappate via dalla galassia principale in un incontro ravvicinato
con una galassia vicina. |
|
|
|
Tabella
1.
Nella tabella sono indicati in
colore i gruppi compatti di cui si presentano nell'articolo le immagini
CCD. Gli altri sono i gruppi del Catalogo di Hickson che dovrebbero essere
alla portata degli astrofili, selezionati con il criterio che il componente
principale sia di magnitudine inferiore alla 15 e che il gruppo contenga
almeno tre membri di magnitudine inferiore alla 16.
Si invitano i lettori a tentare
la ripresa di questi oggetti e a inviare i risultati ottenuti all'indirizzo
e-mail:
e.prosperi@itisfedi.pt.it
| I
gruppi compatti osservabili con strumenti amatoriali |
|
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
|
|
1
|
And
|
UGC 248
|
14,4
|
3/4
|
00h 26,1m
|
+25°,7
|
|
|
2
|
Psc
|
UGC 312
|
13,4
|
4/4
|
00h 31,4m
|
+8°,5
|
|
|
7
|
Cet
|
NGC 192
|
12,6
|
4/4
|
00h 39,3m
|
+0°,9
|
|
|
8
|
And
|
MCG+4-3-8
|
14,5
|
4/4
|
00h 49,6m
|
+23°,6
|
|
|
10
|
And
|
NGC 536
|
12,6
|
4/4
|
01h 26,4m
|
+34°,7
|
|
|
15
|
Cet
|
UGC 1624
|
14,3
|
6/6
|
02h 07,9m
|
+2°,2
|
|
|
16
|
Cet
|
NGC 835
|
12,8
|
4/4
|
02h 09,4m
|
-10°,1
|
|
|
18
|
Ari
|
ARP 258
|
14,9
|
4/4
|
02h 39,2m
|
+18°,4
|
|
|
19
|
Cet
|
MCG-2-7-73
|
14,0
|
3/4
|
02h 42,6m
|
-12°,4
|
|
|
21
|
Eri
|
NGC 1099
|
13,9
|
5/5
|
02h 45,4m
|
-17°,7
|
|
|
22
|
Eri
|
NGC 1199
|
12,2
|
5/5
|
03h 03,6m
|
-15°,6
|
|
|
25
|
Cet
|
UGC 2690
|
13,9
|
5/7
|
03h 20,8m
|
-1°,1
|
|
|
30
|
Eri
|
MCG+0-12-51
|
12,9
|
4/4
|
04h 36,3m
|
-2°,8
|
|
|
31
|
Eri
|
NGC 1741
|
12,5
|
3/4
|
05h 01,6m
|
-4°,3
|
|
|
37
|
Cnc
|
NGC 2783
|
13,0
|
4/5
|
09h 13,7m
|
+30°,0
|
|
|
40
|
Hya
|
ARP 321
|
13,4
|
4/5
|
09h 38,9m
|
-4°,8
|
|
|
41
|
UMa
|
UGC 5345
|
13,9
|
3/4
|
09h 57,7m
|
+45°,3
|
|
|
42
|
Hya
|
NGC 3091
|
11,7
|
4/4
|
10h 00,2m
|
-19°,6
|
|
|
44
|
Leo
|
NGC 3190
|
11,5
|
4/4
|
10h 18,1m
|
+21°,8
|
|
|
51
|
Leo
|
NGC 3651
|
13,9
|
7/7
|
11h 22,4m
|
+24°,3
|
|
|
52
|
Leo
|
MCG+4-27-36
|
14,9
|
3/4
|
11h 26,3m
|
+21°,1
|
|
|
53
|
Leo
|
NGC 3697
|
12,9
|
3/4
|
11h 28,8m
|
+20°,8
|
|
|
56
|
UMa
|
ARP 322
|
14,5
|
3/5
|
11h 32,8m
|
+52°,9
|
|
|
57
|
Leo
|
NGC 3753
|
13,6
|
7/8
|
11h 37,9m
|
+22°,0
|
|
|
58
|
Leo
|
NGC 3822
|
13,6
|
5/5
|
11h 42,2m
|
+10°,3
|
|
|
59
|
Leo
|
IC 736
|
14,4
|
4/5
|
11h 48,5m
|
+12°,7
|
|
|
61
|
Com
|
NGC 4169
|
12,6
|
4/4
|
12h 12,3m
|
+29°,2
|
|
|
62
|
Vir
|
NGC 4759
|
13,4
|
4/4
|
12h 53,1m
|
-9°,2
|
|
|
64
|
Vir
|
PGC 46975
|
14,7
|
3/4
|
13h 25,8m
|
-3°,9
|
|
|
67
|
Vir
|
NGC 5306
|
12,7
|
4/4
|
13h 49,2m
|
-7°,2
|
|
|
68
|
CVn
|
NGC 5353
|
11,8
|
5/5
|
13h 53,4m
|
+40°,3
|
|
|
69
|
Boo
|
UGC 8842
|
14,9
|
3/4
|
13h 55,2m
|
+25°,1
|
|
|
70
|
CVn
|
IC 4371
|
14,5
|
5/7
|
14h 04,2m
|
+33°,3
|
|
|
71
|
Boo
|
IC 4381
|
13,8
|
3/4
|
14h 11,0m
|
+25°,5
|
|
|
72
|
Boo
|
ARP 328
|
13,9
|
4/6
|
14h 47,9m
|
+19°,1
|
|
|
73
|
Boo
|
NGC 5829
|
13,3
|
1/5
|
15h 02,7m
|
+23°,3
|
|
|
75
|
Ser
|
CGCG 135-50
|
14,9
|
4/6
|
15h 21,6m
|
+21°,2
|
|
|
76
|
Ser
|
NGC 5944
|
14,4
|
4/7
|
15h 31,8m
|
+7°,3
|
|
|
79
|
Ser
|
|
13,8
|
5/5
|
15h 59,2m
|
+20°,8
|
|
|
82
|
Her
|
NGC 6162
|
14,1
|
4/4
|
16h 28,4m
|
+32°,9
|
|
|
88
|
Aqr
|
NGC 6978
|
13,2
|
4/4
|
20h 52,6m
|
-5°,7
|
|
|
89
|
Aqr
|
MCG-1-54-12
|
14,1
|
3/4
|
21h 20,0m
|
-3°,9
|
|
|
92
|
Peg
|
NGC 7320
|
12,5
|
5/5
|
22h 36,1m
|
+34°,0
|
|
|
93
|
Peg
|
NGC 7550
|
12,6
|
5/5
|
23h 15,3m
|
+19°,0
|
|
|
94
|
Peg
|
NGC 7578
|
13,9
|
4/7
|
23h 17,2m
|
+18°,7
|
|
|
95
|
Peg
|
NGC 7609
|
14,4
|
3/4
|
23h 19,5m
|
+9°,5
|
|
|
96
|
Peg
|
NGC 7674
|
13,5
|
3/4
|
23h 28,0m
|
+8°,8
|
|
|
97
|
Psc
|
IC 5357
|
14,2
|
4/5
|
23h 47,4m
|
-2°,3
|
|
|
98
|
Psc
|
NGC 7783
|
13,7
|
2/4
|
23h 54,2m
|
+0°,4
|
|
|
99
|
Peg
|
UGC 12897
|
14,0
|
3/5
|
00h 00,6m
|
+28°,4
|
|
|
100
|
Peg
|
NGC 7803
|
13,7
|
3/4
|
00h 01,4m
|
+13°,1
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Legenda |
|
|
|
|
|
| a |
Numero
nel catalogo di Hickson (HCG) |
|
| b |
Costellazione |
|
| c |
Galassia
più luminosa del gruppo |
|
| d |
Magnitudine
della galassia più luminosa del gruppo |
|
| e |
Numero
di galassie con mag.<16 / numero totale di galassie del gruppo |
|
| f |
A.R.
(2000.0) |
|
| g |
Dec.
(2000.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bibliografia
-
Oltre ai due articoli citati si sono utilizzati i seguenti
riferimenti:
-
Hickson, Paul - Systematic properties of Compact Groups of
Galaxies - ApJ, vol, 255, 15 apr. 1982
-
Hickson, P.; Kindl, E.; Auman, J. R. – A photometric
catalog of compact groups of galaxies - ApJ, vol. 70, 08/1989
-
Mendes de Oliveira, C.; Hickson, P. – The luminosity function
of compact groups of galaxies - ApJ, vol. 380, 10/1991
-
Palumbo, G. C. et Alii – Compact groups of galaxies and large-scale
structure – ApJ, vol. 405, 03/1993
-
Mendes de Oliveira, C.; Hickson, P. – Morphology of galaxies
in compact groups – ApJ, vol. 427, 06/1994
-
Gottlieb, S. - Quintets, Sextets and Septets: Exploring Hickson
Compact Groups - S&T, vol. 97, 03/1999
-
Riferimenti Web:
-
http://home.t-online.de/home/andreas.domenico/index.htm
-
http://www.angelfire.com/id/jsredshift/index.html
-
http://members.aol.com/anonglxy/hickson.htm - Quintets, Sextets
& Septets
-
http://www.naoj.org/index.html - Subaru Telescope
-
http://www.noao.edu/image_gallery/galaxies.html - AURA/NOAO
Image Library
-
http://astro.caltech.edu/mirror/keck/realpublic/gen_info/gallery/space.html
- W.M. Keck Observatory
|
|
articolo di Enrico Prosperi
- l'astronomia n.205 - rubrica Profondo Cielo - gennaio 2000
|