|
A
due passi dal polo: il gruppo di galassie di M81
Enrico Prosperi
Articolo pubblicato sul numero 217 (febbraio
2001) della rivista
l'Astronomia, rubrica Profondo
Cielo
|
Sommario |
|
|
|
|
|
|
-
Figura 1.
Riprese CCD dell'autore degli oggetti di cui si parla nell’articolo
-
Figura 2.
L'immagine in falsi colori nell'ultravioletto di M81 ripresa con l'Ultraviolet
Imaging Telescope (UIT)
-
Figura 3.
La regione centrale di M82, di dimensioni 2',5x2',5, ripresa dal telescopio
Hubble.
-
Figura 4.
Le immagini di M82 nel visibile (a sinistra) e nell'ultravioletto (a destra),
tratta dalla ripresa dell'UIT
|
|
|
-
Figura 5.
NGC2403 e UGC4305 sono qui mostrate in colore. (dal DSS 2)
-
Figura 6.
Ammassi stellari ed un'enorme nube di gas luminescente nella galassia NGC
2366 (HST)
|
|
Una
visione d'insieme
Un notevole gruppo di galassie, costituito da almeno
una dozzina di membri, si raggruppa attorno a due oggetti del catalogo
di Messier: M81 e M82.
Queste due galassie sono situate in posizione assai ravvicinata, distanziate
di 36', nella costellazione dell'Orsa maggiore, ad una ventina di gradi
dal Polo Nord Celeste e manifestano un'evidente interazione fisica che
coinvolge anche la più piccola NGC3077,
essendo immerse nel medesimo alone gassoso, come testimoniano osservazioni
nella banda radio. Le tre galassie risultano contemporaneamente presenti
nel campo visuale di un telescopio, con bassi ingrandimenti. Il gruppo
occupa la porzione di nord-ovest della costellazione e si addentra, oltre
il margine occidentale, nella Giraffa, dove si incontra un altro dei suoi
componenti principali, NGC2403. Quest'ultima
galassia è una delle maggiori, nell'emisfero boreale, ad essere
omessa nel catalogo dell'astronomo francese. Inoltre, con oltre 20', è
anche una delle più estese, risultando appena più piccola
di M81 che si allunga per oltre 25' nella direzione dell'asse maggiore. |
| Le tre galassie principali presentano una
notevole luminosità superficiale nella porzione centrale e sono
facilmente individuabili con l'ausilio di un buon binocolo e sotto un cielo
adeguatamente buio. Alcuni osservatori, in condizioni eccezionali, hanno
affermato di essere riusciti a scorgere M81,
la più luminosa, addirittura ad occhio nudo. Cosicché, questa
galassia, distante circa 12 milioni di anni-luce, rappresenta l'oggetto
celeste più lontano visibile senza l'ausilio di alcuna strumentazione. |
 |
La sua posizione si individua facilmente, a partire da
Phecda (gamma) e Dubhe
(alfa), le due stelle che si collocano ai vertici opposti, quello
di sud-est e di nord-ovest, rispettivamente, della coppa del Gran Carro.
Infatti, si colloca sul prolungamento, in direzione nord-ovest, della congiungente
tra queste due stelle, ad una distanza da Dubhe di poco più
di 10°, pari a quella che le separa. Attorno a M81
ed a poca distanza da questa si raggruppa la maggior parte dei membri principali
del gruppo. Prendendo questa galassia per riferimento, si incontra poco
più a nord M82, mentre a circa
45', in direzione ESE, si può osservare NGC3077.
NGC2976 si trova 1°,4 in direzione
sud-ovest e IC2574, la Nebulosa
di Coddington, è a circa 3° ad est. A quasi 2°
da M82, in direzione nord-ovest, si incontra UGC5139.
In posizione alquanto decentrata, 13°,5 a OSO di
M81, nella Giraffa, ci si imbatte nella seconda galassia del gruppo,
sia per estensione sia per luminosità, NGC2403.
Attorno a questa galassia, anche se in posizione alquanto discosta, si
incontrano NGC2366, 3°,6 più
a nord, ancora nella Giraffa, e UGC4305,
ad oltre 6° in direzione nord-est, nell'Orsa Maggiore. Tutte le galassie
fin qui citate, anche se con qualche difficoltà per quanto riguarda
le ultime due e la IC2574, possono
essere osservate con l'ausilio di un buon binocolo o di un piccolo telescopio.
Altre tre galassie che fanno parte del gruppo sono, invece,
di magnitudine attorno alla 15a o ancora
più deboli, e risultano di difficile osservazione per gli astrofili.
Si tratta di M81 dwA, che si colloca
a meno di 30' a nord di UGC4305, UGC4459
5°,9 ad est di NGC2403 e M81 dwB,
1°,1 a nord-est di M82. |
Tabella
1.
| Componenti
del gruppo di galassie di M81 |
|
Denominazione
|
A.R.
|
Dec.
|
Mag.
|
Dimens.
|
Disp.
|
Moto
|
Tipo
|
Supernovae / Note
|
| |
h m s
|
° ' "
|
|
'
|
°
|
Km/sec
|
|
|
| M81=NGC3031 |
09 55 33,5
|
+69 04 00
|
7,9b
|
27,1x14,2
|
157
|
-49
|
Sb
|
1993J
|
| NGC2403 |
07 36 32,6
|
+65 36 39
|
8,9b
|
22,1x12,4
|
127
|
107
|
Sc
|
1954J
|
| M82=NGC3034
(ARP337) |
09 55 54,0
|
+69 40 57
|
9,3b
|
11,3x4,2
|
65
|
300
|
IRR
|
1986D(*)
|
| NGC3077 |
10 03 21,1
|
+68 44 02
|
9,9v
|
5,5x4,0
|
52
|
-16
|
IRR
|
|
| NGC2976 |
09 47 15,6
|
+67 54 50
|
10,8b
|
5,9x2,6
|
143
|
11
|
Sc
|
|
| IC2574 |
10 28 22,5
|
+68 24 59
|
10,8b
|
13,2x5,3
|
47
|
-4
|
DWRF SP
|
|
| UGC4305
(ARP268) |
08 19 06,0
|
+70 42 51
|
11,1b
|
7,9x6,2
|
15
|
157
|
DWRF IR
|
|
| NGC2366 |
07 28 54,4
|
+69 12 52
|
11,5b
|
8,2x3,3
|
25
|
87
|
IRR
|
|
| UGC5139 |
09 40 24,0
|
+71 11 00
|
12,6v
|
4,0x3,3
|
116
|
136
|
DWRF IR
|
|
| UGC4459 |
08 34 06,0
|
+66 10 00
|
14,7b
|
1,5x1,3
|
120
|
6
|
DWRF IR
|
|
| M81
dw A |
08 18,7
|
+71 12
|
|
|
|
262
|
|
(**)
|
| M81
dw B |
10 05,5
|
+70 22
|
14,94p
|
1,2x0,9
|
|
185
|
DWRF IR
|
(**)
|
(*) Falso allarme: ulteriori indagini
dimostrarono trattarsi di un nodo in M82.
(**) Fonte: Brent Tully, Nearby
Galaxy Catalog |
I
componenti della porzione centrale
|
| M81
(NGC3031) è, per estensione
e luminosità, la galassia principale del gruppo: la magnitudine
visuale, infatti, è di 6,9 e costituisce uno degli oggetti la cui
visione risulta maggiormente appagante per un osservatore dell'emisfero
settentrionale. Si tratta di una stupenda spirale di tipo Sb, inclinata
di circa 60° rispetto al piano di vista ed orientata in senso SSE-NNO.
L'aspetto è dominato dal rigonfiamento centrale, assai brillante
ed esteso, da cui si dipartono due stretti e serrati bracci di disegno
regolare, punteggiati da alcuni nodi, di dimensioni contenute, costituiti
da stelle giovani, di recente formazione ed in cui non si notano regioni
ricche di gas e polveri. Un tratto tipico é dato da uno dei due
bracci che si divide in due a nord del nucleo, appena prima di inclinarsi
decisamente verso sud. La distanza di questa galassia è stata determinata
con l'uso del telescopio spaziale Hubble mediante l'individuazione di 32
cefeidi ed è attualmente stimata in 12 milioni di anni-luce. A questa
distanza, l'estensione di quasi mezzo grado corrisponde ad un diametro
di poco inferiore ai 100 mila anni-luce, simile a quello della Via Lattea. |
 |
Figura
1. Al centro una ripresa panoramica della regione centrale, di
2° di lato, del gruppo di M81, situato nell'Orsa Maggiore. L’immagine
è tratta dal Digitized Sky Survey (DSS) del Palomar Observatory
Sky Survey (POSS I). Nei riquadri sono presentate le riprese CCD dell'autore
di alcune galassie di cui si parla nell’articolo.
Osservatorio Astronomico di Castelmartini
(Pistoia) - codice osservatorio: MPC 160. Telescopio: Schmidt-Cassegrain
di 254mm di apertura, operante a f/6,3 oppure a f/4,8; camera CCD: Hi-SIS
22 equipaggiata con Kodak KAF-0400. Le immagini sono il risultato della
somma mediana di riprese multiple in binning 2x2, ciascuna con posa di
45”, preventivamente calibrate. |
| Attorno a M81 troviamo la maggior
parte dei membri più rilevanti del gruppo. |
Le analisi dinamiche paiono confermare
che, solo poche decine di milioni di anni fa; sia avvenuto un incontro
ravvicinato di questa galassia con M82
(NGC3034), che ha dato origine ad un'intensa
formazione stellare. L'evento ha sconvolto e distorto l'aspetto di quest'ultima
galassia che mostra una forma altamente irregolare, con la porzione centrale
punteggiata da un cospicuo numero di globuli assai luminosi e da tracciati
oscuri di gas e polveri. Le porzioni centrali delle due galassie sono oggi
separate di appena 150000 anni-luce.
Dal punto di vista morfologico, M82 è un'irregolare
a disco, disposta di profilo ed inclinata in direzione ENE-OSO. È
detta Galassia Sigaro per la sua forma allungata ed è stata inserita
con il numero 337 da Arp nel suo catalogo di galassie peculiari.
Dalla porzione centrale, in direzione perpendicolare rispetto all'orientamento
della galassia, emergono e si diffondono nello spazio dei getti gassosi
che sono visibili anche nelle riprese CCD amatoriali e che paiono originati
dall'intensa attività di formazione stellare e dal conseguente elevato
tasso di esplosione di supernovae. |
 |
| Figura 2.
L'immagine in falsi colori nell'ultravioletto di M81 ripresa con l'Ultraviolet
Imaging Telescope (UIT) nel corso della missione Astro-1, dalla navetta
spaziale Columbia. Qui è stata sovrapposta a quella nel visibile
(in giallo-rosso) per evidenziare i nodi di intensa formazione stellare
nei bracci della galassia. |
| Per l'intensa attività nel suo nucleo,
viene classificata come Seyfert ed è la più prossima di questo
tipo. La luminosità nell'infrarosso è prorompente tanto da
essere la galassia più luminosa dell'intero cielo in questa banda.
Fu scoperta, assieme a M81, da Johan Elert Bode l'ultimo giorno
del 1774. |
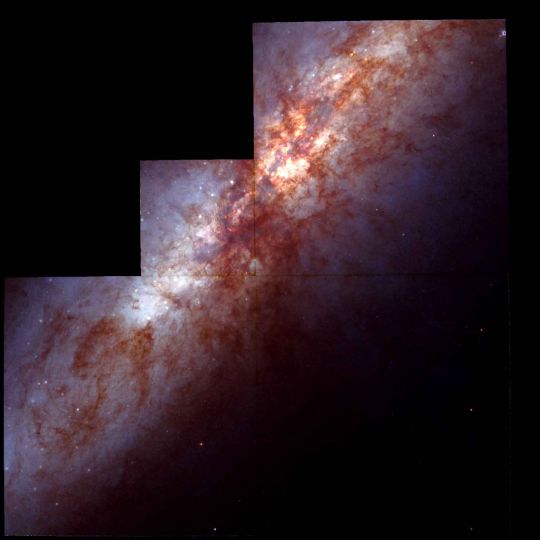 |
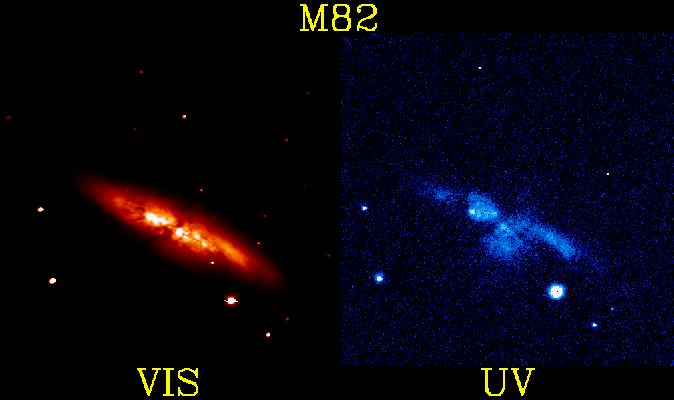 |
| Figura 3.
La regione centrale di M82, di dimensioni 2',5x2',5, ripresa dal telescopio
Hubble. |
Figura 4.
Le immagini di M82 nel visibile (a sinistra) e nell'ultravioletto (a destra),
tratta dalla ripresa dell'UIT. Si osservi l'intensa attività di
formazione stellare che pervade la galassia in tutta la sua estensione. |
Due membri più piccoli del gruppo si trovano nelle
immediate vicinanze delle due compagne maggiori. Si tratta di NGC3077,
di mag. 10, che ha l'apparenza di un'ellittica, allungata in senso NE-SO,
ma viene classificata come peculiare per la presenza di tracciati diffusi
di materiale oscuro che l'attraversano in direzione radiale, soprattutto
nella sua porzione sud-occidentale, e per la presenza di un nucleo galattico
attivo. L'altra è NGC2976, una
galassia peculiare il cui disegno a spirale risulta confuso, oltre che
dall'inclinazione rispetto al piano visuale, dalla struttura caotica caratterizzata
da un nucleo di aspetto stellare e dalla presenza diffusa di gas e polveri
e di numerose condensazioni.
Pochi gradi più ad oriente rispetto a queste galassie,
si trova IC2574, una debole spirale
nana, che non presenta alcuna evidente addensamento centrale, mentre è
visibile una barra, orientata in senso SO-NE, con la presenza di alcune
condensazioni nel corto braccio settentrionale che si diparte verso occidente
dal margine della barra. Un altro membro di debole luminosità superficiale
è UGC5139 (Holmberg I),
una galassia irregolare nana con poche e deboli regioni HII, a poco più
di 1°,5 da M82, in direzione nord-ovest. Un'altra galassia nana irregolare,
di colorazione bluastra, che presenta una luminosità maggiore della
precedente e dimensioni doppie, è UGC4305
(Holmberg II), in posizione periferica, in prossimità del
margine occidentale dell'Orsa Maggiore. Sono visibili diverse e cospicue
condensazioni costituite da regioni HII e di formazione stellare. È
inclusa con il numero 268 nel catalogo di Arp. |
La
propaggine del gruppo nella Giraffa
Quest'ultima galassia fa parte di un raggruppamento secondario
che ha le maggiori componenti in NGC2403 e NGC2366, nella
costellazione della Giraffa, a pochi gradi dal margine con l'Orsa Maggiore. |
NGC2403
è una notevole spirale Sc (o Scd), di magnitudine visuale 8,4, con
bracci aperti e punteggiati da numerose e cospicue regioni HII e associazioni
OB. L'aspetto morfologico e le proprietà globali sono simili a quelli
di M33 e si presenta leggermente inclinata, rispetto al piano di
vista, allungandosi per oltre 20' in direzione SE-NO.
Più a nord si colloca NGC2366,
una galassia irregolare, di tipo analogo alle nubi di Magellano, che si
allunga in senso SO-NE. |
 |
| Figura 5.
NGC2403 e UGC4305 sono qui mostrate in colore. Le immagini sono elaborazioni
dell'autore a partire dai dati in banda blu (B) e rossa (R) rese disponibili
dal Palomar Observatory Sky Survey di seconda generazione (POSS 2). L'immagine
monocromatica di UGC5139 è quella in banda B. |
| Ad ovest del suo margine meridionale si osserva
un addensamento secondario, NGC2363:
si tratta di una gigantesca regione HII. Un'altra cospicua regione HII,
di dimensioni inferiori ma di luminosità superficiale più
elevata rispetto alla precedente, si trova nella porzione meridionale della
galassia ed è stata indagata recentemente con l'ausilio del telescopio
spaziale Hubble. |
 |
| Figura 6.
Ammassi stellari ed un'enorme nube di gas luminescente splendono assai
luminosi nella galassia di tipo magellanico NGC 2366: si tratta di una
gigantesca regione di formazione stellare, ripresa dal telescopio orbitante
Hubble. A dispetto della distanza di oltre 10 milioni di anni-luce, il
telescopio spaziale Hubble risolve dettagli confrontabili a quelli visibili
in analoghe nebulose nella nostra galassia. |
articolo di Enrico
Prosperi - l'astronomia n.217 - febbraio 2001
|
|